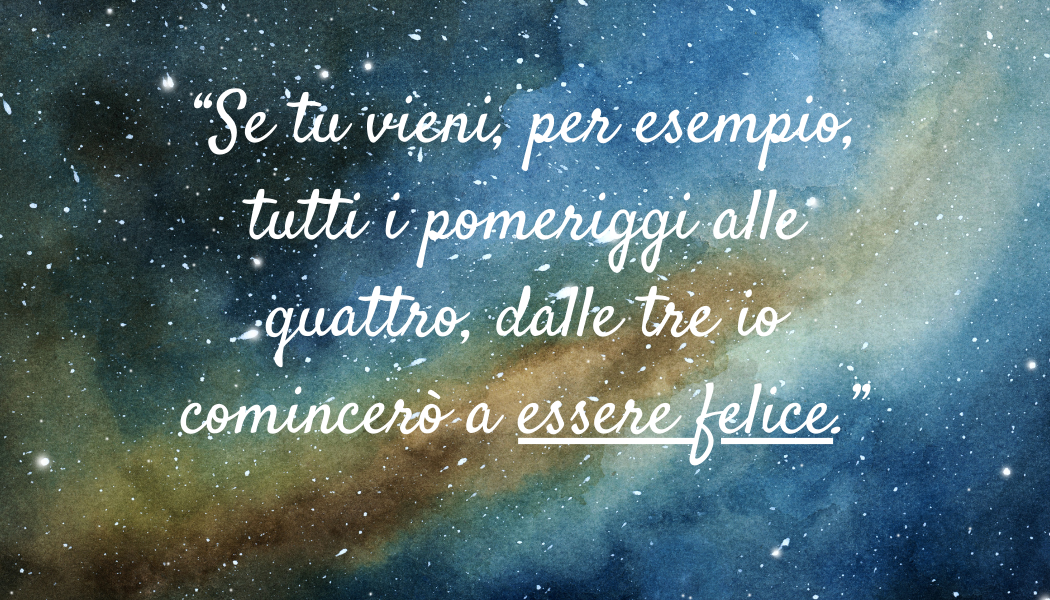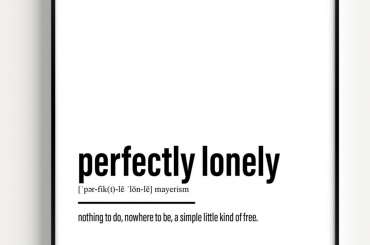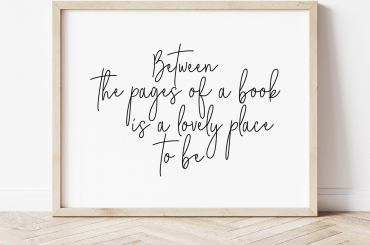– Ma tu chi sei?
– Hai fatto un bel ruzzolone e mi sei quasi caduto addosso. Adesso non agitarti e cerca di muoverti piano.
La mia testa faceva fatica ad elaborare le informazioni. Ricordavo di essere in bici. Ricordavo di essere sulla via di casa. Null’altro. Ed ora ero sdraiato a terra, con una strana moretta vicino, tutto indolenzito. E mi sembrava notte fonda. Il sentiero era buio ed il cielo ancor più nero.
Nel frattempo mi ero riuscito a sedere. Tutto funzionava a dovere. Niente fratture. Nemmeno sangue. Le botte, i dolori e gli ematomi usciranno domani, pensai.
– Fai piano, non sforzare.
– Si, si, grazie. Non preoccuparti, sto bene.
Nel buio vedevo due begli occhi castani. Due mani con le dita lunghe e magre. Delle belle unghie, curate, non troppo lunghe, forse con uno smalto rosa tenue. Mani che mi toccavano, delicatamente, accompagnando i movimenti del mio corpo nel tentativo di mettermi seduto.
Ok. Ero in piedi. Dolorante ma in piedi. Il telefono indicava le 21:17. Non era possibile. Il giro in bici l’avevo iniziato nel pomeriggio ed avevo preso la strada del ritorno al calare del sole, verso le 16:30. Che era successo in quasi cinque ore?
– Scusa, ma sono davvero le nove e ventuno?
– Si, potrebbe essere. Ma io non ho orologi. Il tempo non conta.
– Non so come ringraziarti.
Era estremamente carina e dolce. Allo stesso tempo appariva sicura di sé ed, in un certo modo, quasi dominante. No, sporcaccioni, non dominante nel senso di fruste, manette e uomini sottomessi. Lo era nel modo di fare, una persona abituata a decidere, a comandare gli altri, a farsi rispettare. Piccolina, magrolina e molto carina. Indossava una t-shirt chiara, dei pantaloncini corti e delle scarpe da montagna. Niente zaino o borse.
Mi guardai attorno in cerca della bicicletta. Non vedevo nemmeno il caschetto e lo zainetto, che non sentivo sulla schiena.
– Vieni, non preoccuparti – come mi avesse letto nel pensiero – ho portato le tue cose a casa.
Senza una parola, senza obiettare o fare domande, ci siamo incamminati lungo il sentiero. Era buio pesto, una notte senza luna, forse nascosta dalle nuvole o semplicemente ancora da spuntare dalle cime. Avevo perso l’orientamento. Non mi ritrovavo nel sentiero e non capivo la zona in cui eravamo. Avremmo dovuto essere sul versante della valle opposto alla mia baita. Ma non ricordavo ci fossero altre case di fronte.
Anche lei stava in una baita. Molto piccola. Semplice, essenziale, sembrava rimasta al secolo scorso. Si notava che un tempo era una stalla, sul lato opposto alla porta d’entrata c’era ancora la mangiatoia lungo tutto il muro. Non c’era corrente elettrica ma candele accese. Un tavolo, una panca angolare, due sedie sgangherate, una stufa e quello che sembrava un giaciglio più che un letto. Sul tavolo c’erano il mio caschetto e lo zainetto da bici. Non avevo visto la bici.
– La tua bicicletta è qui fuori. Dietro.
Ancora una volta aveva risposto al mio pensiero. Ma chi era questa tizia? Ero privo di forze, quasi svuotato, con la mente rallentata ed una pigrizia incredibile, come se in pensieri facessero fatica ad essere elaborati, pochi, lenti ed incapaci di uscire come domande. Ma sarà stata davvero la caduta? Avrò sbattuto la testa? Non avrò mica un trauma cranico? Ma no, il caschetto era integro e senza nemmeno un graffio. Non avevo dolori al viso. Nemmeno sangue. Le gambe non erano graffiate.
– Non ti sei fatto nulla, stai tranquillo. Solo un gran bella capriola.
Si era avvicinata alla stufa e stava versando dell’acqua calda in due tazze di metallo smaltato. Antiche e sbeccate. Si era voltata e mi aveva fatto cenno di sedermi sulla panca. Mi ritrovai seduto, con la tazza in mano, mescolando quello che mi sembrava del the. Mi guardava, con dolcezza, sorridendo come per rassicurarmi, in silenzio. Non capivo, avevo paura, non capivo di cosa, ma sentivo che avrei dovuto fidarmi. Non avevo timore di nulla in particolare, ma tutta la situazione era alquanto strana. Chi era? cosa mi era successo? Cosa voleva?
– Ma tu vivi qui? Non avevo mai visto questa baita.
– Si, vivo anche qui.
Era gentile. Una bella voce rassicurante. Di certo non loquace. Ogni risposta era breve e non lasciva aperto un dialogo. Mi guarda, sorridendo con gli occhi. Sembrava avesse piacere nel capire la mia frustrazione ed il mio imbarazzo per la situazione.
Dovevo andarmene. Dovevo ritornare a casa. Sulla bicicletta avevo montato una piccola torcia a led, sarebbe stata sufficiente per ritornare, con calma lungo il sentiero e riprendere la strada sull’altro versante della valle.
– Non è il caso di uscire ora. Sii paziente. Tra poco sarà l’alba ed potrai percorrere il sentiero con la luce.
Ancora. Un’altra volta mi aveva risposto ad una domanda mai fatta. Ero sempre più preoccupato. Avevo un senso di confusione. Sembrava un sogno. Ma ero sveglio e tutto era reale. Toccavo il tavolo. Mi sentivo in carne ed ossa. Magari è così morire. Che strano pensiero. Non ero mica morto.
La bevanda era un infuso di erbe. Gustoso e particolare. Stavo meglio. Sentivo meno dolori e mi sembrava di non aver nemmeno sonno. Mi sentivo quasi in forma.
La stavo guardando mentre lavava le tazze, constatando con sorpresa che un raggio di sole la illuminava da dietro. Aveva lunghi capelli nero. Piccolina. Aggraziata.
Ma come era possibile? un attimo fa eravamo al buio a sorseggiare il thè, o quello che era, ed ora c’era già il sole. Il telefono, quasi scarico, indicava che erano le 9:10. Non era possibile. Non c’era campo. Batteria quasi esaurita al 5%. Avevo deciso di andarmene, stavo pensando a cosa dire, a come ringraziare.
– Si, ora sarà più facile tornare a casa, ormai è giorno.
Non le avevo chiesto nulla. E mi stava rispondendo girata, mostrandomi le spalle. Vedevo metà viso. Un viso dolce, da bambina, ma si vedeva che era un’adulta. Non capivo l’età. Aveva un naso lungo. Un’imperfezione adorabile, che la rendeva unica e bellissima ai miei occhi. Ora la potevo osservare meglio. Si era cambiata. Ma quando? Indossava un vestitino a fiorellini su sfondo blu scuro. Maniche corte. Ai piedi un paio di sandali, tipo birkenstock, di pelle marrone. Piccoli piedini affusolati, piedi greci con il secondo dito più lungo. Il piede di Venere. Ne vado pazzo. Adoro il piede di Venere, simbolo di bellezza classica, assoluta. Niente smalto. Anche le mani erano senza smalto. Piccole mani dalle dita lunghe.
Ero in piedi. Imbarazzato. Non sapevo cosa dire, quasi intimorito.
Mi aveva accompagnato fuori, alla bicicletta. Perfettamente integra.
– Come posso ringraziarti? Non so nemmeno il tuo nome.
– Non serve ringraziare. Le cose accadono quando e come devono accadere. Tutto è sempre già scritto. L’importante è trovarsi al posto giusto, nel momento giusto e predisposti ad accogliere gli eventi. Tutto trova sempre il suo incastro perfetto, prima o poi.
Non avevo parole. Probabilmente era la frase più lunga che avevo sentito uscire dalle sue labbra. Ero incantato. Non sapevo il suo nome.
– Mi chiamo Lavinia.
– Che bel nome. Ti si addice. Io mi chiamo Adam.
– Lo so come ti chiami. Ti conosco da tanto. Ci conosciamo da molto.
Non capivo. Lei mi stava sorridendo. Occhi vispi, intensi, profondi e che ridevano.
– Ora vai. Ci rivedremo presto. Abbi cura di te.
Ora sono a casa. Non capisco. Quando sono arrivato Argo mi ha fatto delle feste incredibili, con delle corse circolari come un pazzo sul prato. Io sto bene. Non ho dolori, non ho sonno, non capisco cosa sia successo.
Non è stato un sogno. Come lo so? Perchè nello zainetto da bici ho trovato una pacchettino di carta di giornale, con delle erbe triturate. Lo accompagnava un bigliettino: “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò a essere felice.”
La conosco. E’ una frase del Piccolo Principe. Libro che ho odiato da bambino, libro che ho poi capito e compreso da adulto. Libro che adoro. Uno dei più belli mai letti, che rileggo spesso, aprendo a caso le sue pagine. In realtà il paragrafo continua, spiegando il prezzo della felicità.